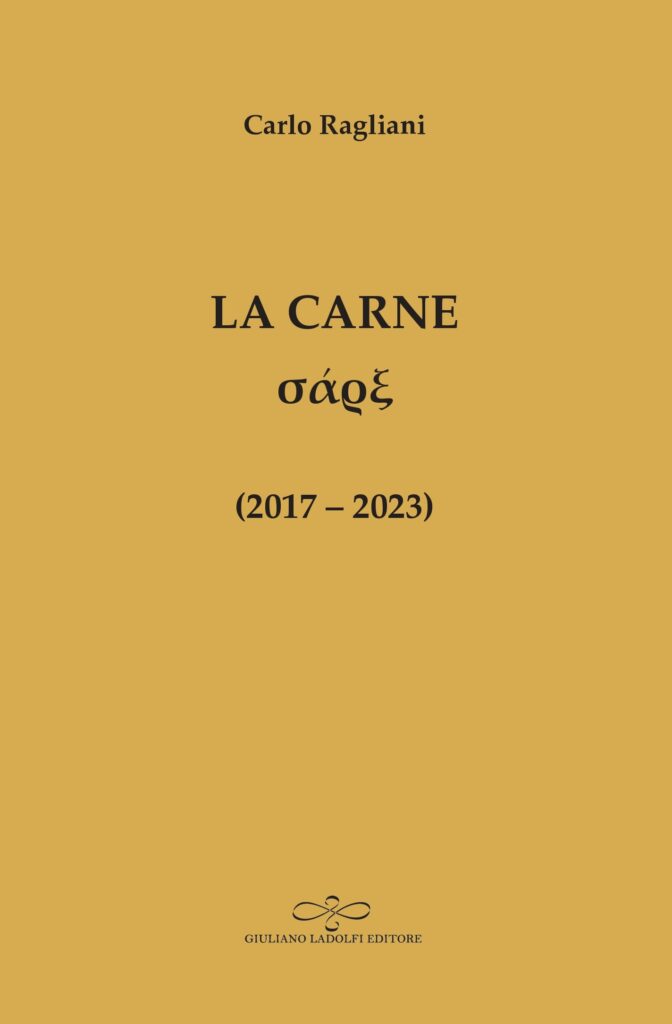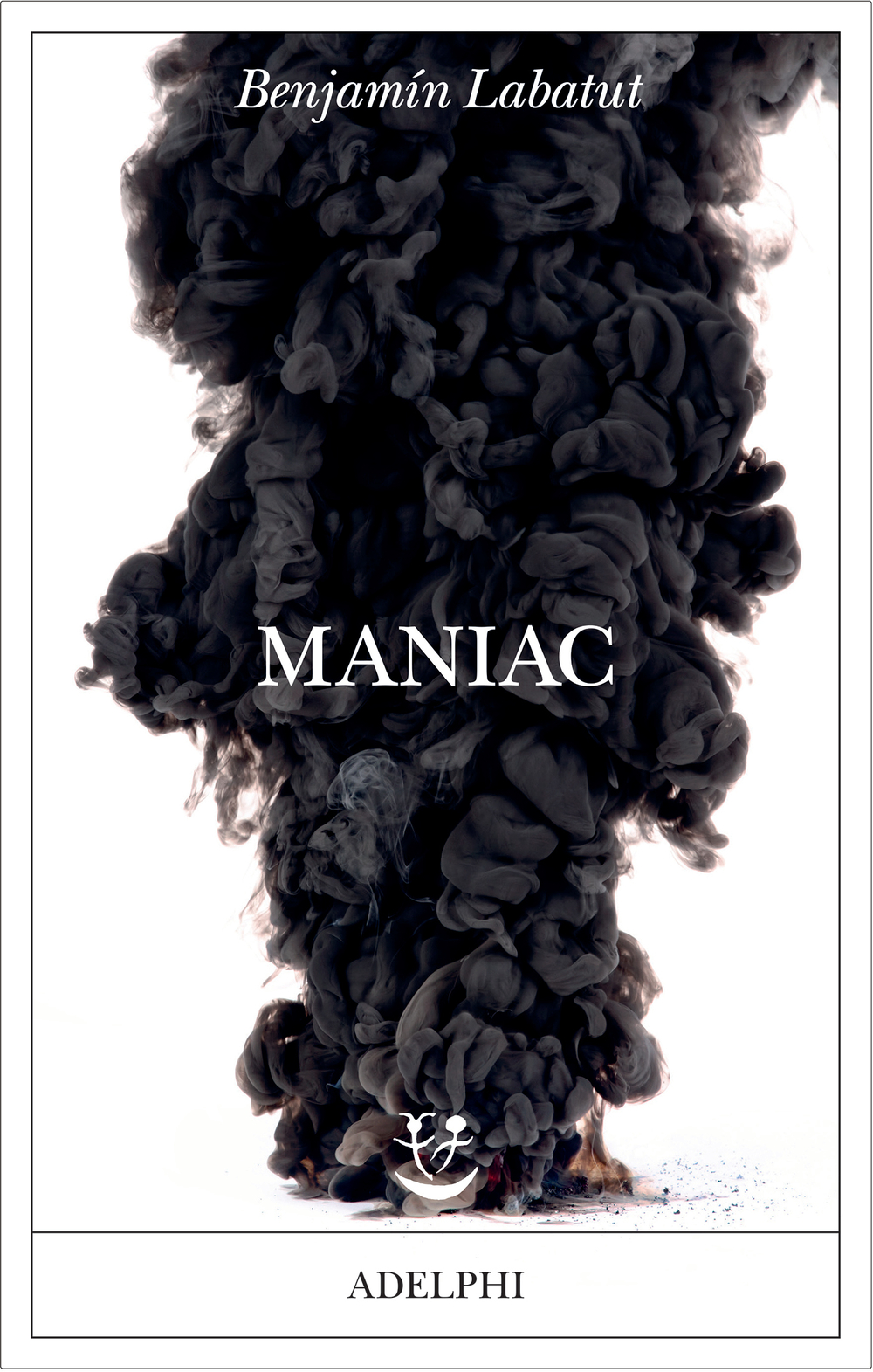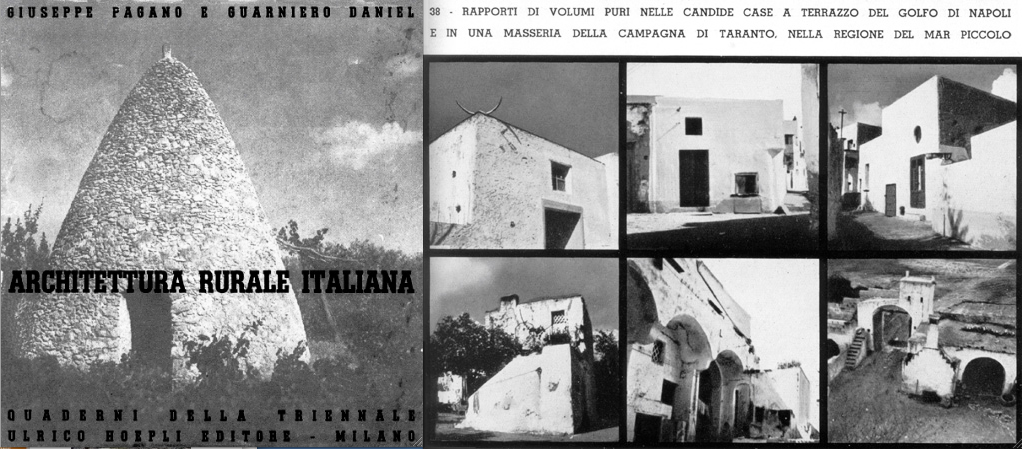È da poco uscito per Biblion edizioni Maestri contro. Brioschi, Guglielmi, Rossi-Landi, un volume di saggi a cura di Paolo Giovannetti e mia. L’iniziativa è nata da un seminario organizzato alla Statale di Milano il 10 febbraio 2023, grazie al contributo importante di Laura Neri. In quell’occasione, ci dividemmo per gruppi: Laura Neri, Stefania Sini e Lorenzo Cardilli intervennero su Franco Brioschi, Cecilia Bello, Stefano Colangelo, Massimiliano Manganelli e Chiara Portesine su Guido Guglielmi, Simona Menicocci, Ezio Partesana, Francesco Maria Terzago ed io su Rossi-Landi. Oltre a Paolo Giovannetti, era presente nel ruolo di moderatore Giorgio Mascitelli.
Di Andrea Inglese
Una filosofia del linguaggio pionieristica
A Ferruccio Rossi-Landi si confà perfettamente il titolo del nostro incontro, e nel duplice significato di essere controcorrente – fuori dalle mode e dalle tempistiche intellettuali del suo paese – e contro in senso teorico e politico, in quanto difende una concezione “militante”, seppure minoritaria, del sapere sull’uomo e il linguaggio. Si batte, insomma, non solo contro un modello di sapere ma anche di società, che quel sapere legittima. A ciò si aggiunga una pratica precoce dell’interdisciplinarità e del dialogo serrato tra filosofia e scienze umane (linguistica, semiotica, economia).
Rossi-Landi è stato dunque un pioniere nell’ambito della ricerca intellettuale. Si trova a Oxford l’anno stesso della morte di Wittgenstein (1951). E di Wittgenstein coglie tutta la portata critica nei confronti sia del positivismo logico che della successiva filosofia analitica. Del 1961 è il suo primo libro, Significato, comunicazione e parlare comune, in cui propone una lettura critica dei presupposti fondamentali della filosofia analitica. Ora, un tale lavoro non poteva essere recepito dalla filosofia italiana, ancora ignara del dibattito analitico e non ancora arricchita del confronto con la linguistica e la semiotica, come avverrà invece durante la temperie strutturalista. Il pensiero di Rossi-Landi continua a evolvere sul filo di un dialogo tra il secondo Wittgenstein e Marx. È del 1966 un suo articolo dal titolo “Per un uso marxiano di Wittgenstein”. Ed anche questa nuova direzione di ricerca lo colloca, nel panorama italiano, in una posizione assai solitaria. Ma la singolarità del suo percorso è riscontrabile fin nei suoi lavori più tardi, come Metodica filosofica e scienza dei segni del 1985, pubblicato l’anno della sua scomparsa.
Un piccolo esempio non tanto dell’inattualità di Rossi-Landi, ma del fatto che ancora non sia stata assimilata la sua lezione, è la smilza pagina che gli dedica Wikipedia. Di certo, il suo isolamento intellettuale e l’originalità di una ricerca in perpetua evoluzione hanno favorito anche il formarsi di alcuni nodi irrisolti nel suo pensiero. Ne sono testimonianza, oggi, studi di giovani ricercatori, che hanno come ambizione di riconsiderare i fondamenti teorici del suo pensiero in un’ottica critica e di ulteriore chiarificazione. A questo proposito è importante citare almeno la recente monografia di Giorgio Borrelli dal titolo Ferruccio Rossi-Landi. Semiotica, economia e pratica sociale (Edizioni dal Sud, 2020). Essa conferma che, seppure con ritardo, esiste un nuovo interesse per il nostro autore e non solo da un punto di vista puramente storiografico, ma anche teoretico e militante.
Per quanto mi riguarda, non ho certo le competenze per avanzare valutazioni sulle sue tesi maggiori, né posso spacciarmi per uno studioso della sua opera. Agirò, però, con l’opportunismo metodologico che caratterizza spesso il lavoro di riflessione sulla letteratura, ossia metterò in rilievo alcuni punti del pensiero di Rossi-Landi, sperando che risultino utili per chiarire aspetti importanti della pratica poetica contemporanea.
Ideologie letterarie e olismo antropologico: Rossi-Landi e Descombes
Se la lirica si è imposta come genere dominante della poesia moderna, nulla ci dice, stando almeno alla situazione italiana, che questo dominio si sia inequivocabilmente esaurito, nonostante i più svariati annunci di un oltrepassamento di portata storica. “Dopo la lirica”, insomma, il lirismo sembra tutt’ora vivo e vegeto come anche il quadro ideologico che lo giustifica. Così è, di conseguenza, per la contestazione del lirismo e per alcuni dei suoi presupposti teorici. Pratiche di poesia anti-lirica o semplicemente non lirica sono tutt’ora rivendicate, e spesso attraverso un inevitabile riferimento alla tradizione novecentesca delle avanguardie. Se siamo d’accordo nel riconoscere questi tratti molto generali del paesaggio poetico attuale (almeno in Italia), è importante sottolineare che la partizione conflittuale tra postura lirica e postura non-lirica trae le proprie risorse ideologiche da ideali complementari e, spesso, intrecciati indissolubilmente.
Nel paradigma lirico, l’enunciato poetico deve realizzare una restituzione (verbale, ritmica, musicale) di un’integrità o di una totalità perduta, quella dell’esperienza individuale e autentica, del vissuto silenzioso che precede l’impoverimento imposto dal discorso ordinario, attraverso cui la persona comune è costretta a esprimere ciò che gli accade e la sua visione del mondo. Nel paradigma alternativo e minoritario, che fa riferimento alle avanguardie, il valore dell’enunciato poetico pertiene al suo carattere emancipatore, ossia alla sua possibilità di affrancarsi, attraverso procedimenti verbali più o meno innovativi – sia di tipo grafico e visivo, che orale e performativo –, dalle costrizioni ideologiche e culturali di una società data. Questi ideali – integrità ed emancipazione – si presentano sia in modo intrecciato che separato sul piano delle poetiche. Possiamo avere una poesia lirica, che predica l’emancipazione dagli stereotipi veicolati dalla lingua comune così come una poesia sperimentale o di ricerca che persegue l’utopia di un “realismo integrale”. A monte, però, agiscono dei costrutti ideologici più complessi (e anche più confusi) che legittimano questi ideali, e la loro influenza sulle pratiche di scrittura.
Se consideriamo il paradigma lirico, è inevitabile fare riferimento all’espressivismo nelle sue forme per lo più ingenue[1], ossia a un complesso di idee basato sulla partizione tra individuo-esperienza-interiorità, da un lato, e società-linguaggio comune-esteriorità, dall’altro. La versione ingenua dell’espressivismo presuppone che l’individuo poetante possegga una qualche forma di esperienza privata e interiore, da salvaguardare rispetto alla traduzione che il linguaggio comune finisce per farne, spogliandola della sua ricchezza originaria. Se prendiamo in conto, invece, le forme contestatrici del paradigma lirico, legate a gesti di rottura avanguardistici o sperimentali, ritroviamo spesso una sorta di rovesciamento ideologico degli ideali espressivisti. In tale prospettiva, è l’esteriorità della lingua a costituire il soggetto – e quindi l’individuo poetante –, non lasciando ad esso nessuna riserva interiore d’autenticità, ma anche nessuna zona mentale immune dalla penetrazione dell’ideologia. Si rischia d’imbattersi, qui, in una versione più o meno riduttiva sia di certi assunti strutturalisti che post-strutturalisti.
Più in generale, nel piccolo universo delle ideologie letterarie, si riflette un fenomeno che, pur avendo caratterizzato la crisi della modernità, continua a ripresentarsi come nuovo e assillante nell’epoca attuale. La società contemporanea sembra perennemente minacciata da una duplice e contraddittoria condizione: da un lato, la rottura del legame sociale, l’atomizzazione dell’io e la conseguente diffusione di un pernicioso narcisismo di massa; dall’altro, un controllo e un condizionamento sociale illimitati, che espongono il singolo senza difese al dominio delle istituzioni e dei centri di potere economico e tecnologico. Il caso delle piattaforme digitali è da questo punto di vista esemplare. Da un certo punto di vista, non vi è dispositivo sociale in grado di inverare nel modo più diffuso, democratico e capillare gli ideali espressivisti: attraverso le finestre dei “social”, ognuno ha la possibilità di “scegliere se stesso”, ovvero di costruire un’immagine e un discorso che siano la più libera e autentica espressione di sé, mettendo in secondo piano la lunga lista delle proprie “appartenenze”. Non a caso, le piattaforme sono anche accusate di accrescere le posture narcisistiche degli individui, rendendo questi ultimi sempre più ciechi nei confronti della diversità di condizioni, esperienze e prospettive presenti nella società. Le finestre di Facebook e Instagram banalizzano e rendono in qualche modo operativo l’imbroglio concettuale del solipsismo: ”l’unico mondo che esiste è il mio mondo”. D’altra parte, queste oasi di libertà selvaggia, dove i desideri dell’individuo trionferebbero su ogni vincolo collettivo, si rivelano, in realtà, sfere opache sottoposte a forme di condizionamento e sfruttamento ampiamente inconsapevoli. Ogni giorno, attraverso la volontaria “connessione”, non accediamo soltanto a strumenti di comunicazione multimediale di cui non abbiamo deciso architettura e funzioni, ma forniamo ininterrottamente dati sul nostro comportamento che potranno essere utilizzati, nel migliore dei casi, per arricchire grandi aziende, e nel peggiore, per accentuare il controllo o il condizionamento nei nostri confronti, da parte di soggetti terzi (privati o statali).
Queste prospettive simultanee e antitetiche sembrano riconducibili alle due opzioni ideologiche, di cui si sono serviti studiosi, critici e poeti nel corso della seconda metà del Novecento: ideali espressivisti e difesa dell’autenticità individuale versus sparizione del soggetto e onnipotenza delle strutture linguistiche impersonali. Su questo gioco di specchi tra l’espressivismo come quadro ideologico del lirismo e lo strutturalismo o post-strutturalismo come quadro ideologico di certo avanguardismo, si è espresso anche Italo Testa nel suo recente saggio “Teoria della poesia”, inserito nel volume Teoria della letteratura a cura di Laura Neri e Giuseppe Carrara (Carocci, 2022, p 204).
È pur vero che in una certa misura una concezione meramente soggettivista e psicologista dell’espressivismo sembra divenire egemonica in una certa fase della teoria della poesia moderna e contemporanea, finendo per generare una reazione oggettivista, un partito preso delle cose che ne ribalta gli assunti, e finisce per sfociare nella «morte del soggetto» strutturalista.
Ora ciò che ci permette di mettere fuori gioco sia il quadro espressivista sia quello riduzionista che gli si oppone è una filosofia del linguaggio come quella di Rossi-Landi, che si accompagna a una più generale concezione antropologica. Fin dalla sua prima opera del 1961, Significato, comunicazione e parlare comune, egli considera il fatto linguistico come un fatto sociale globale. Ciò significa considerare che la comunicazione di significati è una pratica sociale, che si apprende e si esercita all’interno di un intreccio di quelli che Wittgenstein chiamava giochi linguistici e forme di vita. Questo intreccio costituisce una totalità, un orizzonte comune a tutti i parlanti, anche se si articola attraverso una gran ricchezza di pratiche e di universi discorsivi particolari. (Alle spalle di Rossi-Landi vi sono i concetti di “spirito oggettivo” hegeliano, di “cosmologia” secondo Charles Sanders Peirce, di “prassi” secondo Marx e di “semiotica” secondo Charles Morris.)
Secondo quest’ottica, il linguaggio è quindi un sistema inseparabile di segni verbali e segni non-verbali, di attitudini comportamentali e di modelli d’enunciazione. Impossibile, quindi, presuppore forme di “privatezza” o d’“interiorità” dell’esperienza individuale che precedano il formarsi del “soggetto umano” entro le strutture sovrapersonali di una società storicamente data. Il concetto stesso d’intersoggettività è messo in crisi, in quanto esso implica l’esistenza di singole esperienze soggettive, che si troverebbero poi nella condizione di accordarsi e d’istituire significati comuni. In altri termini, è respinto il pregiudizio contrattualistico che sta alla base della varie forme di “individualismo metodologico”, ancora in uso nelle diverse scienze umane. Scrive Rossi-Landi, in Semiotica e ideologia (Bompiani, 1972/2000, p. 24):
quando gli individui si mettono a parlare non esprimono affatto un proprio accordo, non concorrono affatto in un contratto, non aderiscono ad alcuna convenzione, non stringono alcun patto; bensì soltanto imparano una tecnica comunitaria cui partecipano attivamente quali erogatori di lavoro linguistico, ma che subiscono in modo pressoché totale per quanto riguarda le modalità tecniche.
Il concetto di “lavoro linguistico”, che permette agli individui di produrre e scambiare “enunciati”, è quindi inseparabile non da proprietà della mente, della coscienza o del cervello, ma innanzitutto da “tecniche comunitarie”, il cui esercizio ovviamente presuppone determinate condizioni biologiche, ma che non è in alcun caso riducibile a esse. Le tecniche sono pratiche di significazione, che permettono a un individuo di produrre un significato (verbale o non verbale) per un altro individuo. Questo implica che l’istituzione di una certa tecnica precede i due individui (e i loro eventuali “stati mentali”) nelle circostanze dell’interlocuzione, ed è trasmessa a entrambi dalla società in cui vivono. Una tale concezione della comunicazione linguistica ha conseguenze radicali: – cito sempre da Semiotica e ideologia – 1) “In nessun caso il lavoro linguistico va inteso come attività interiore del soggetto, come ‘atti intenzionali’ od ‘operazioni mentali’ che si svolgerebbero necessariamente nella psiche conscia o inconscia dei singoli individui realisticamente intesa (…)” (p. 35); 2) bisogna respingere, a sua volta, “un pregiudizio individualistico di tipo idealistico o spiritualistico, secondo il quale gli individui sarebbero preformati alla loro convivenza sociale” (24-25).
Rossi-Landi difende quella che filosofi contemporanei come Vincent Descombes definiscono una concezione olistica della mente e della vita sociale, precisando che i due termini sono qui sinonimi: vi è “mente”, laddove vi è “società”, ossia un mondo di significati comuni, e non semplicemente intersoggettivi. In Les institutions du sens (Minuit, 1996, p. 333), Descombes formula il concetto di olismo antropologico e riconduce le “tecniche comunitarie” di Rossi-Landi agli “usi”, con riferimento alla sociologia francese di Marcel Mauss:
Questi usi sono delle istituzioni nel senso di Mauss, sono della maniere di fare e di pensare, di cui gli individui non sono gli autori. Gli individui sono certamente gli autori delle frasi che costruiscono, ma non sono gli autori del senso di queste frasi, ed è precisamente quel che si vuole dire, parlando di un significato impersonale degli enunciati.
Tale concezione olistica permette anche di delucidare una delle questioni che sono cruciali per le scienze umane, ma anche per quelle naturali, ossia l’ominazione, la formazione dell’animale uomo, in quanto animale “sociale” e “parlante”. Scrive Rossi-Landi in Linguistica ed economia (Mimesis, 2016, p. 36-37):
l’ominazione con tutti i processi che la compongono va intesa come affatto antecedente all’uomo. Assumere che, in generale, ci sia nell’individuo umano qualcosa di già formato significare negare l’interpretazione storico-materialistica dell’ominazione. Ciò vale quando l’elemento assunto è di tipo spirituale come quando è di tipo biologico: sia che lo riduca a qualcosa che sta al di fuori della storia perché lo sovrasta, sia che lo si riconduca a qualcosa di precedente alla storia e di estraneo ad essa. Studiare l’ominazione in senso storico-materialistico significa invece ricondurre l’uomo a processi comunitari che lo precedono ma poi anche lo accompagnano come uomo in generale […].
Programmazione sociale e autonomia individuale
Ora, se una tale impostazione olistica mette fuori gioco l’espressivismo ingenuo e i suoi pregiudizi contrattualistici e mentalistici, essa è confrontata alla difficoltà di rendere conto, da un lato, dell’integrazione del nuovo venuto in una totalità di senso connessa a una data società e una data lingua, e, dall’altro, della capacità di quest’ultimo di esercitare, nel corso di questa integrazione, un’autonomia e persino una critica nei confronti delle norme acquisite. Si tratta di concepire come possono convivere il carattere sociale e globale dei significati, e nello stesso tempo la capacità di gruppo o individuale di metterli in discussione, senza fare riferimento a un’interiorità di tipo extrastorico (naturale, biologico, pre-sociale) o sovrastorico (spirituale, razionale – in senso kantiano -, ecc.).
Per quanto riguarda il processo di integrazione, Rossi-Landi parla di programmazione e di programmi. In Ideologia (Isedi, 1978, p. 198), scrive: “Gli individui imparano cioè a eseguire programmi che sono stati elaborati da precedente lavoro umano sociale. Si diventa membri della società in quanto, anche senza saperlo, se ne accettano i prodotti e si impara ad adoperarli”. È il necessario apprendimento dei “programmi” che permette sia all’individuo di interagire con la società già costituita, sia a quest’ultima di conservare la coesione dei gruppi sociali e dei valori. Il rapporto dei singoli gruppi sociali alla programmazione non è, però, privo di conseguenze sul piano ideologico e politico. Il fatto di aver sottolineato questo aspetto è probabilmente l’apporto più importante di Rossi-Landi alle concezioni olistiche del sociale. In questo quadro concettuale, egli inserisce il concetto (storico-materialistico) di “classe dominante”, “come la classe che possiede il controllo dell’emissione e circolazione dei messaggi verbali costitutivi di una data comunità” (in Semiotica e ideologia, pp. 205-206). La programmazione sociale, quindi, è sempre ideologica, in quanto favorisce un gruppo sociale (la classe dominante[2]) a scapito di un altro (la classe dominata). Ciò significa, allora, che la partecipazione degli individui alla comunicazione (il loro specifico lavoro linguistico per produrre enunciati) è inevitabilmente alienato.
Giunto su questo terreno, il pensiero di Rossi-Landi sembra preso in un movimento contraddittorio: è indispensabile accrescere la consapevolezza del condizionamento sociale, ossia del peso della dominazione di classe, additando ogni aspetto della vita sociale e discorsiva in cui essa è presente, ma, nello stesso tempo, è necessario elaborare un quadro concettuale che implichi la possibilità per individui o gruppi sociali di emanciparsi da essa. Ritroviamo il rischio di ogni enfasi messa sul potere delle strutture sovrapersonali – sistemi semiotici o dispositivi specifici di “fabbricazione” della soggettività di tipo foucaultiano. Come si sfugge, in tale prospettiva, all’alienazione diffusa, conquistando una forma di autonomia individuale? Rossi-Landi cerca di sciogliere questo nodo, affermando che, nonostante ogni interazione verbale o non-verbale sia frutto di programmazione sociale, è possibile concepire programmazioni innovative, e soprattutto programmazioni liberatorie. Non è, però, così chiaro come un soggetto individuale o collettivo passi dalla semplice esecuzione di un programma ereditato, a un programma liberatorio e di rottura. Ma questo è un problema tipico di una concezione olistica del mentale (e della società). In un saggio dedicato a Descombes (“L’apport de la philosophie de Vincent Descombes aux sciences sociales”), inserito in un libro collettivo del 2020 (Le social et l’esprit, a cura di F. Callegaro e J. Xie, éditions EHSSS, p. 21) Alain Ehrenberg, Irène Théry e Philippe Urfalino lo individuano lucidamente: “Come conciliare la constatazione di un’iscrizione del pensiero individuale nell’universo sociale che lo precede e lo oltrepassa (…) ?” Come insomma lasciare uno spazio di autonomia all’interno di pratiche non verbali e verbali interamente condizionate da un sistema sociale e dalla sua ideologia?
M’interessa considerare a questo punto se, in Rossi-Landi, la poesia possa svolgere un qualche ruolo di emancipazione, di apertura oltre la programmazione sociale ereditata. D’altra parte, la principale dimensione politica insita nella poesia risiede proprio nella pretesa di aprire uno specifico spazio – ritualizzato finché si vuole – in cui sia possibile verificare un’esteriorità almeno relativa del parlante rispetto al codice discorsivo a cui è sottoposto. Ora, come già ricordato all’inizio, tale pretesa attraversa, dalla modernità in poi, sia il campo del genere lirico sia quello delle rotture avanguardistiche. Nel saggio introduttivo al suo recentissimo libro, Autorizzare la speranza. Giustizia poetica e futuro radicale (Interlinea, 2023, p. 8), è ancora Italo Testa, con riferimento ad Adorno, a ricordarlo: il dire poetico autorizza la speranza in un mondo che ancora non c’è (e che esso comunque non può realizzare): “Ciò non riguarda necessariamente un contenuto utopico determinato, ma investe l’aspetto controfattuale della forma poetica, quella possibilità di mettere a distanza il mondo (…)”.
Perché questa ipotesi di lavoro linguistico specificatamente “poetico” abbia senso, bisogna capire come sfuggire al condizionamento storico-ideologico della lingua, che secondo Rossi-Landi “raggiunge un punto in cui è il linguaggio che si serve di noi” (in Linguistica ed economia, cit., p. 275). Se, insomma, è la lingua dei dominanti che ci parla, non solo ogni forma di critica radicale e contestazione della società esistente è compromessa, ma persino quella “distanza dal mondo”, che la pratica poetica cerca di mettere in scena, di ritualizzare. Ma proprio quando il nostro autore nega al parlante comune un contributo di tipo “creativistico” (nato nella sua libera interiorità), anche valorizza circostanze in cui può avvenire una “messa a distanza” del mondo. Quest’ultima si realizza in un primo tempo non attraverso una “magica” capacità di saltare al di fuori della lingua e dei significati comuni, contrapponendo loro qualcosa di più autentico, intimo, privato, o un semplice gesto di negazione indifferenziata. Come dice Rossi-Landi, il primo passo verso l’emancipazione consiste in un “accrescimento della programmazione umana” (in Ideologia, cit., p. 199) ossia in una presa di coscienza di tutto quanto è implicito e inconsapevole nel lavoro linguistico ordinario. L’autonomia del parlante comincia, ad esempio, con l’esplicitazione dei modelli di enunciato che egli ripete e riprende. Ma questo processo di “accrescimento della consapevolezza” non si fa a partire da un qualche slancio espressivo individuale o in virtù di qualche innata chiaroveggenza dell’intelletto, ma attraverso uno specifico e ulteriore lavoro linguistico sui significati e i modelli di enunciato condivisi socialmente. Scrive Rossi-Landi, in Linguistica ed economia (cit., p. 102):
Per diventare consci dei programmi per l’uso degli artefatti linguistici dobbiamo studiare il funzionamento delle cose che sono già state prodotte. Il singolo lavoratore linguistico raramente procede dai programmi per l’uso ai modelli di produzione, passando sugli artefatti a ritroso, sebbene questo non sia impossibile. Di solito accade solo nella ricerca, nell’invenzione di parole nuove che soddisfano un nuovo bisogno sociale, e nel caso della cosiddetta “creazione” poetica (modificazioni riportate a programmi, o anche ad alcuni modelli di produzione).
Ha quindi ragione chi, nell’universo del consumo letterario, denuncia la poesia come un genere “sbagliato”, elitario o autoreferenziale, in quanto l’enunciato poetico inceppa, rallenta, a volte rende impossibile il normale sviluppo della comunicazione, chiedendo al lettore una complicità in questa operazione di allontanamento da tutto quanto è percepito nella programmazione linguistica come “familiare”, “naturale”, “ovvio”. D’altra parte, la voce “ideologica”, accordata alla concezione dominante di letteratura, dicendo quel che dice, va anche incontro a una contraddizione. Da un lato, si addita l’incresciosa situazione del prodotto “poetico”, che non è una merce letteraria di consumo facile e familiare (friendly, come dicono gli anglosassoni) come invece lo è il romanzo, dall’altro, si denuncia spesso il fatto che “tutti sono poeti”, tutti scrivono, e quindi nessuno legge la poesia. Se questo è anche solo in parte vero, significa che, nonostante le riserve dei critici e degli editori, la “poesia” fa parte di un programma sociale di comunicazione, è qualcosa di condiviso nelle sue linee più generali, anche se i suoi prodotti più “lavorati” (secondo procedimenti di esplicitazione critica) non sono a volte neppure riconosciuti come legittimi frutti di questo programma.
Vediamo di trarre, ora, qualche conclusione da questo percorso attraverso Rossi-Landi e l’olismo antropologico. In primo luogo, sia i testi poetici inscritti nel paradigma lirico sia quelli inscritti in quello delle avanguardie, fanno riferimento a tradizioni, ossia a forme di programmazione sociale, che implicano, a partire dal discorso e dai significati comuni, uno specifico “lavoro linguistico” del “poeta”. Quest’ultimo si trova di fronte a dei programmi “inscatolati” gli uni negli altri, e quindi non solo lavora sui significati comuni, ma anche sugli specifici modelli di enunciato che vengono dalle tradizioni poetiche a cui ha accesso storicamente. Lo “stile” individuale, allora, è semplicemente uno specifico lavoro linguistico, atto a individualizzare l’enunciato poetico, non certo il riflesso di una singolarità biologica, che, in modo misterioso, si tradurrebbe direttamente nel linguaggio. Opporre, allora, la “scrittura” allo “stile” in un’ottica barthesiana, significa semplicemente indicare un diverso orientamento del lavoro linguistico. Non si tratta, quindi, di annunciare la sparizione del soggetto, quanto di sospendere – grazie a un’accresciuta consapevolezza – una serie di automatismi che il perseguimento dello stile personale ha sedimentato nel codice lirico. È su questo terreno che, per un critico attento alla contemporaneità come Gianluca Picconi, si gioca oggi la possibilità di una poesia di ricerca e in particolar modo di un’attitudine “non-assertiva”. Scrive Picconi in La cornice e il testo. Pragmatica della non-assertività (Tic Edzioni, p. 22): “La scrittura non-assertiva potrebbe essere allora il tentativo di determinare il passaggio, in poesia, da stile a scrittura: eliminazione delle componenti individuali irriflesse e istintive, per lasciare spazio a una progettazione capillare ma disindividualizzata dell’oggetto letterario. Disindividualizzare, in particolare, la funzione del testo più cogente alla lirica, ossia l’autore”. Dobbiamo solo precisare, in virtù del discorso fatto fino ad ora, che quelle “componenti individuali” sono “irriflesse e istintive”, come lo sono tutta una serie di attitudini inscritte in un dato programma sociale, attitudini cioè non ancora sottoposte a esplicitazione e distanziamento critico.
Ciò che oggi cerchiamo di definire come il campo della poesia “di ricerca”, è un tipo di lavoro linguistico, interno al programma moderno della poesia, ma che opera simultaneamente su almeno due fronti: quello degli automatismi linguistici del discorso ordinario e quello degli automatismi linguistici insiti nella tradizione del genere letterario a cui fa riferimento. Se la poesia di ricerca e la poesia lirica condividono, in fondo, gli ideali moderni dell’emancipazione, la prima considera che l’affrancamento deve realizzarsi anche rispetto ai caratteri inevitabilmente ideologici (e quindi storici e convenzionali) connessi con lo specifico discorso poetico. Così è stato con la grande crisi della metrica tradizionale, tra fine Ottocento e primo Novecento; così è oggi, ad esempio, con la crisi (o la cancellazione) della distinzione tra verso e prosa nelle scritture poetiche contemporanee. Una tale situazione non sancisce la fine della poesia come istituto sociale ancora prima che letterario – del resto, non è certo un gruppo di poeti, pur talentuosi e innovatori, che potrà farlo. Essa mostra, semmai, che il processo d’individualizzazione dell’enunciato poetico può avere tutt’ora un senso, ma si realizza attraverso prosaici procedimenti o dispositivi, che poco hanno a che fare con la singolarità biologica del poeta, e molto, invece, con lavorazioni linguistiche specifiche che ambiscono sia a modificare il programma sociale della poesia sia i modelli di enunciati che essa veicola. Anche la poesia di ricerca, quindi, essendo frutto di lavoro linguistico, implica un’intenzionalità soggettiva, e non si realizza in forme anonime o de-soggettivate – questo potrebbe avvenire nei casi di poesia realizzata attraverso l’Intelligenza Artificiale, somma espressione di automatismi linguistici. Quello che rischia di sparire dall’orizzonte è allora soltanto il presupposto ideologico di ogni lavorazione su programmi e modelli linguistico-letterari, ossia quella singolarità extrastorica – sostrato biologico o psicologico – di un autore, garante di uno stile fatalmente unico.
[1] Una forma non ingenua di espressivismo è quella elaborata dal filosofo canadese Charles Taylor, che cerca di comprendere gli ideali espressivisti attraverso una genealogia della modernità e di fornirne una descrizione, che integri gli apporti della “svolta linguistica”. L’espressione di sé è allora un’articolazione personale, realizzata attraverso il linguaggio comune, di modelli, norme, valori ereditati dalla società (moderna) in cui viviamo.
[2] Oggi possiamo complicare lo schema marxiano classe dominante-classe dominata, inserendo altre partizioni e subordinazioni sociali: di genere, di orientamento sessuale, relative al gruppo etnico.
___________
“Rossi-Landi: programmazione sociale e poesia” è stato scritto da andrea inglese e pubblicato su NAZIONE INDIANA.
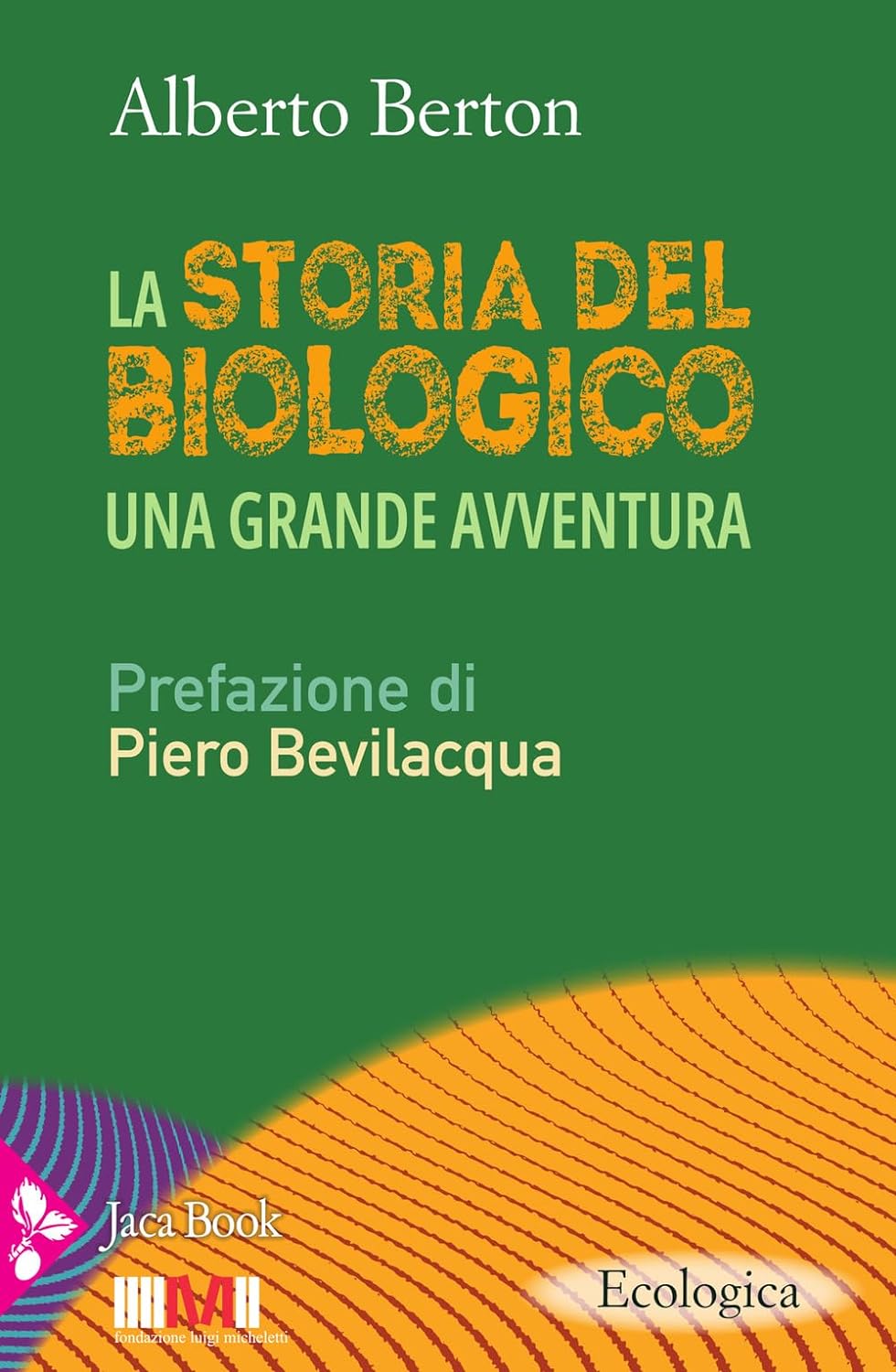 Nonostante alcuni deboli tentativi di fare della bioeconomics di Georgescu-Roegen la base teorica della bioeconomy[1], l’impostazione dell’economista rumeno resta fondata su una ‘visione del mondo’ che non ha nulla a che vedere con la bioeconomia com’è oggi comunemente intesa. Come si diceva all’inizio, un caso emblematico, quello della bioeconomia, in cui l’uso del suffisso bio genera grandi confusioni[2].
Nonostante alcuni deboli tentativi di fare della bioeconomics di Georgescu-Roegen la base teorica della bioeconomy[1], l’impostazione dell’economista rumeno resta fondata su una ‘visione del mondo’ che non ha nulla a che vedere con la bioeconomia com’è oggi comunemente intesa. Come si diceva all’inizio, un caso emblematico, quello della bioeconomia, in cui l’uso del suffisso bio genera grandi confusioni[2].